Percorsi
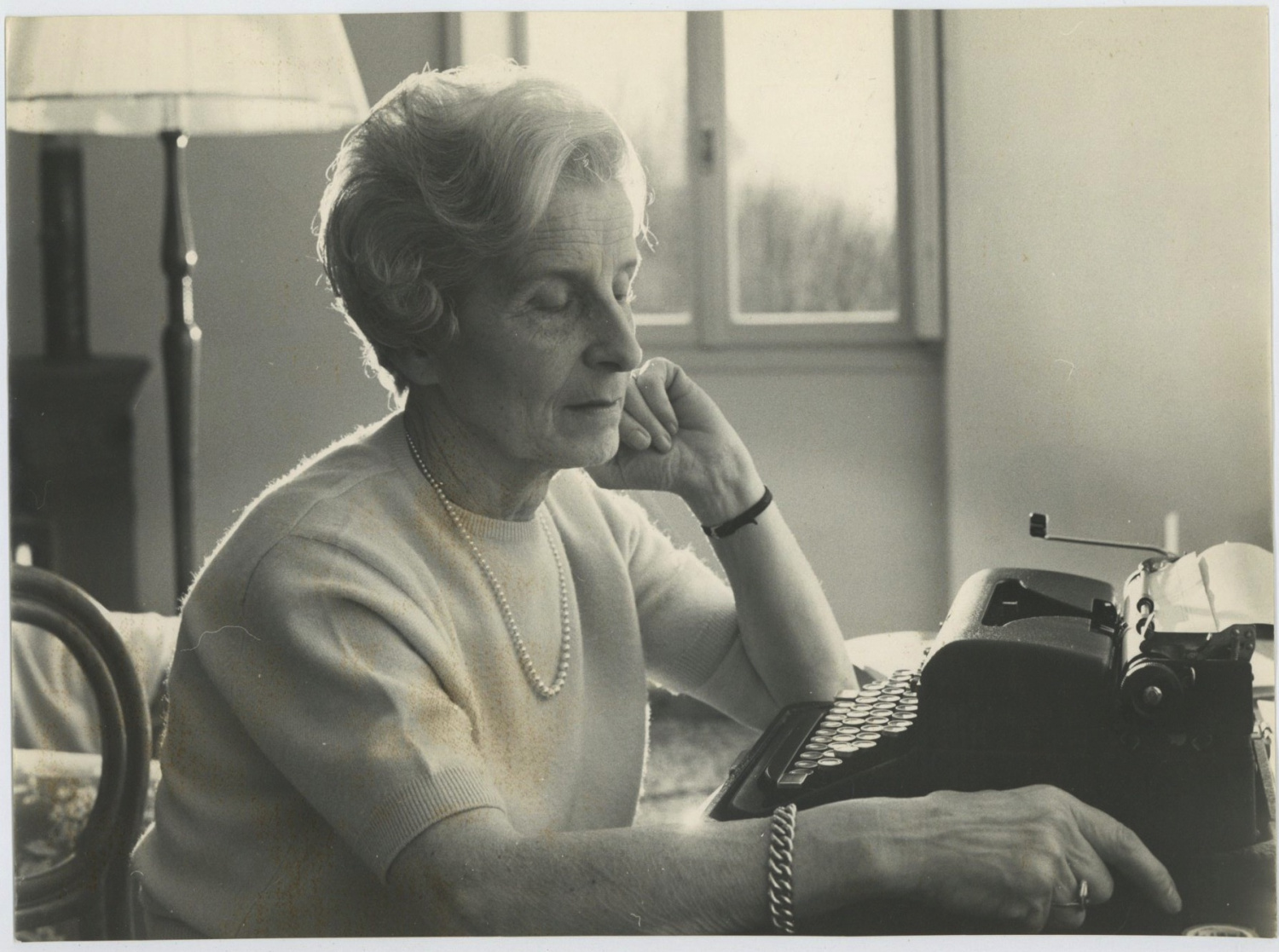
Il monito di Adorno «fa parte della morale non sentirsi mai a casa propria»[1] si adatta bene a Fausta Cialente: la presa di distanza, il suo essere «straniera dappertutto»,[2] sono un filo conduttore che attraversa tanto le sue vicende biografiche e politiche quanto il suo percorso letterario. Nelle opere di Cialente si rintracciano spesso il senso di disappartenenza e l’assenza di una patria,[3] temi che sembrano approdare a una risoluzione nelle Quattro ragazze Wieselberger[4] con il ritorno a un lessico famigliare, dispositivo simbolico di ricostruzione dell’unica Heimat possibile.
[1] Theodor W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, Einaudi, Torino 1953, p. 29.
[2] Così Cialente si definisce nell’intervista di Sandra Petrignani apparsa sul «Messaggero» il 16 ottobre 1983, poi in Ead., Le signore della scrittura. Interviste, La Tartaruga, Milano 1984, pp. 83-89 (aggiungendo: «mi domando se d’italiano ho solo la lingua»); ma si veda anche l’Avvertenza dell’autrice nella ristampa di Cortile a Cleopatra, Feltrinelli, Milano 1962, p. 16: «Straniera e distaccata mi sentivo anche in Egitto»; e l’Introduzione alla ristampa delle Quattro ragazze Wieselberger, Mondadori, Milano 1978, p. X: «sono sempre dovunque straniera (d’italiano credo di avere soltanto la lingua nella quale mi esprimo e anche questo per puro caso)».
[3] Cfr. Andrea Gialloreto, Sognando una patria «mai esistita»; gli eroi raminghi di Fausta Cialente tra utopia comunitaria e crisi di disappartenenza, in «Critica Letteraria», XXXIII, 128 (2005), pp. 467-501, poi in Id., L’esilio e l’attesa. Scritture del dispatrio da Fausta Cialente a Luigi Meneghello, Carabba, Lanciano 2011; e Sara Faccini, Lo sradicamento di Fausta Cialente e il suo “sempre fuori dalla patria”, in Scrittori e intellettuali italiani del novecento on the road, a c. di B. Van den Bossche e I. de Seta, Franco Cesati Editore, Firenze 2020, pp. 195-204. Vd. anche Roberto Salsano, Interculturalismo e plurilinguismo in Fausta Cialente. Dai romanzi “levantini” a Le quattro sorelle Wieselberger, in «Rivista di Studi Italiani», III, 1 (2005), pp. 184-191.
[4] Le quattro ragazze Wieselberger, Mondadori, Milano 1976 (l’edizione più recente è del 2018, con prefazione di Melania G. Mazzucco, La Tartaruga, Milano).
